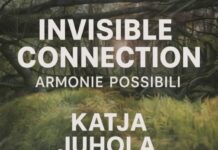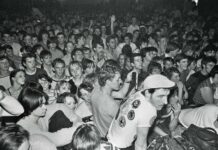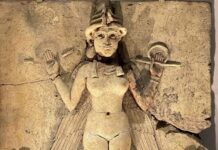Nella grande tragedia del Novecento italiano, troppo spesso la figura di Edda Ciano Mussolini viene ricordata in modo riduttivo e quasi indulgente, come quella di una donna in balia degli eventi, vittima della ferocia del fascismo e delle spietate dinamiche di potere che le strapparono il marito e la costrinsero all’esilio. Ma la maggiore e prediletta figlia del Duce fu tutt’altro che una semplice spettatrice innocente vissuta all’ombra del regime e dei propri familiari: donna capricciosa e ribelle, incarnazione stessa del lusso, dell’arroganza e della mondanità di quegli anni drammatici, Edda fu in realtà la più spietata consigliera del padre, nonché fanatica sostenitrice del Führer e di quelle stesse dittature che finirono poi per travolgerla insieme a tutto ciò che le era più caro, trascinandola irrimediabilmente nell’abisso più oscuro della nostra Storia contemporanea.
Edda Mussolini nacque a Forlì il 1° settembre 1910, primogenita di Benito Mussolini e Rachele Guidi che all’epoca non erano ancora sposati perché avversati dalle rispettive famiglie, in quanto lei era figlia della nuova compagna del padre di lui! Benito aveva avuto altri due figli naturali, da due donne diverse, ma mai riconosciuti.
La nascita di Edda portava già con sé un’aura di leggenda e pettegolezzo: per anni, infatti, circolò la voce che la madre non fosse Rachele, bensì l’anarchica Angelica Balabanoff, amante del futuro Duce. Era ovviamente una diceria falsa e priva di fondamento, ma tanto bastò a suscitare un alone di mistero intorno alla figura della “favorita”, sempre sospesa tra mito e scandalo, erede non solo di un uomo destinato a dominare la scena politica, ma anche di un “dna anarchico” che in qualche modo le apparteneva. Il nome stesso, “Edda”, scelto ovviamente dal padre, evocava forza e ribellione: ispirato alla “super-donna” nietzschiana protagonista del dramma ibseniano Hedda Gabler. Non fu battezzata, in omaggio alle convinzioni anticlericali dell’ambiente familiare, e solo molti anni più tardi, alla vigilia del Concordato, ricevette il sacramento per necessità politica.
Trascorse l’infanzia nella povertà assoluta; inquieta, infastidita dalla presenza dei due fratelli minori Vittorio e Bruno (gli altri due, Romano e Anna Maria, nasceranno quasi vent’anni dopo), insofferente ai divieti e segnata dal mito e dalla dipendenza morbosa per quel padre ingombrante che ricercherà in tutti gli uomini della sua vita e di cui sarà gelosissima fino all’ultimo giorno: “Lei ravvisava nel padre un eroe favoloso. Lo sapeva al centro di storie avvincenti, lo vedeva uscire di casa con la camicia priva di una manica pronto a battersi a duello e poi rincasare graffiato ma trionfante. Ravvisava in lui un uomo di eccezionale valore, mentre nella madre e nella nonna non scorgeva che mediocrità e piattezza”.
A Milano, dove i Mussolini vivevano in via Castel Morrone, Edda mostrò il primo segno del suo carattere capriccioso e anticonvenzionale: tentò di scappare con una carovana di zingari accampata dietro casa. Ricorderà anni dopo la fascinazione per quei bambini vestiti di abiti colorati e per le ruote dei carri che promettevano libertà e avventura: “Avevo una sola idea in testa: andarmene, andarmene, andarmene”. Alla fine non partì, ma quel senso di movimento, di precarietà e di fuga sarebbe rimasto una cifra costante del suo vivere.
L’educazione di Edda non fu mai tenera né tradizionale: respirava l’atmosfera di una famiglia socialista rivoluzionaria, più improntata al dinamismo politico e vitale che alla dolcezza. Accompagnava il padre nelle redazioni, alle stamperie, alle riunioni, apprendendo presto che la vita era movimento, azione, impegno. Non sorprende, quindi, che crescendo si rivelasse irrequieta, anticonformista, assetata di novità. A quattordici anni fumò la sua prima sigaretta, amava correre, saltare, praticare sport considerati poco femminili, e si appassionò, immedesimandosi, ai romanzi avventurosi di Salgari e al mondo delle automobili, allora ancora dominato dagli uomini. Il padre le aveva proibito di studiare danza sostenendo che quel mestiere “conducesse diritto al bordello”! Il duce si esaltava all’idea di avere una figlia “maschiaccio”, motivo per il quale le imponeva i capelli corti e prove di resistenza psicofisica assai pericolose.
Gli studi non furono decisamente il suo punto forte: al liceo Parini collezionò voti mediocri e un infamante “otto in condotta”; all’istituto Regio femminile della SS Annunziata di Firenze, il più elegante e costoso d’Italia, iscritta dal padre ormai Capo del Governo, resistette solo pochi mesi.
Precoce anche nei rapporti con l’altro sesso, seppur non bella, “la cavallina matta”, come la chiamavano in famiglia, ebbe svariate esperienze già a partire dai dodici anni, prima di arrivare al primo vero e proprio fidanzamento con un nobile forlivese, che si interruppe per volere del Duce quando il giovane chiese notizie sulla dote: Edda lo lasciò di buon grado senza la benché protesta! Poco dopo, fra un fugace innamoramento e l’altro, conobbe il nobile affascinante Galeazzo Ciano, figlio di Costanzo, di umili origini ma devoto servitore del regime. Lui, avventato e impulsivo quanto lei, le chiese la mano al primo appuntamento, al cinema, sentendosi rispondere con altrettanta temeraria disinvoltura: “E perché no?”. Tornata a casa, la ragazza annunciò il fidanzamento al padre, che si mise a correre con i pantaloni in mano gridando a Rachele: “Ci siamo! Questa è la volta buona!”.
“Edda scrisse un biglietto di poche righe a Galeazzo, che aveva cominciato a chiamare con lo strano soprannome di Gallo, per comunicargli l’assenso del duce: «Caro Gallo, ho affrontato mio padre che, per un mucchio di bellissime considerazioni sul tuo conto, è stato felicissimo della nostra decisione».
Lei sapeva molto su quel ragazzone, della sua passione per le donne e della inclinazione che le donne avevano per lui. Sapeva che in intimità le sue spasimanti lo chiamavano vezzosamente «Buby» o «Ciccy», ed ecco perché lei volle chiamarlo «Gallo», anche per definire implicitamente galline quelle che frequentavano la sua non troppo segreta garçonnière.”
Il matrimonio fu celebrato a Villa Torlonia il 24 aprile 1930. Dopo la cerimonia, Mussolini fu colto da un attacco di gelosia irrefrenabile e, trascinandosi dietro l’ignara Rachele, si mise all’inseguimento della macchina dei neosposi diretti a Capri, costringendo Edda a fermarsi e a intimargli di tornare indietro. Quel giorno sancì un passaggio importante: Edda, fino ad allora vissuta all’ombra del padre, iniziava una nuova fase. Ma la sua ribellione nei confronti del mondo non si placò mai: fumava, beveva, giocava a poker, indossava pantaloni e bikini, guidava auto sportive, sfidando con spregiudicatezza le convenzioni e i desideri paterni. Mussolini, pur contrariato, non smise mai di proteggerla e di nutrire neanche tanto velatamente una predilezione per questa figlia identica a lui, nei tratti e nel temperamento indomabile, di cui era solito ripetere con orgoglio: “Ho sottomesso l’Italia, ma non lei”.
Con Galeazzo, Edda ebbe tre figli – Fabrizio (detto Ciccino) nato nel 1931 e morto nel 2008 in Costa Rica, dove viveva da oltre 30 anni; Raimonda (detta Dindina) nata nel 1933 e morta nel 1998; Marzio (detto Mowgli) nato nel 1937 e morto nel 1974 neanche quarantenne a causa del diabete – ma il matrimonio, seppur solido, non fu mai idilliaco. L’attrazione fisica svanì presto, mentre si sviluppò un legame psicologico profondo: come se lui trovasse forza nell’avere accanto una moglie così energica e sicura di sé, provando al contempo soddisfazione nel proteggerla dalle sue stesse imprudenze; e come se lei, a sua volta, riuscisse a calmare le proprie inquietudini grazie a quell’indulgente cura materna rivolta al marito leggero, ritrovandosi ad apprezzare – pur essendo così aspra e rigida – i suoi modi arrendevoli da bravo ragazzo italiano, spesso collerico, narcisista, manesco e fedifrago impenitente, ma mai disinteressato a lei o alla famiglia. Entrambi ebbero amanti e flirt chiacchieratisismi, facevano impazzire tutti i salotti e i rotocalchi gossippari del tempo, ma la coppia, per quanto infedele e sconclusionata, era più unita di quel che potesse sembrare esternamente.
Dopo il matrimonio si trasferirono a Shanghai, dove Galeazzo era console generale. Qui erano già notoriamente conosciuti come la “coppia moderna” per eccellenza, apertissima da un punto di vista intimo…e non solo! In fuga perenne da sé stessa, anche dopo il ritorno a Roma Edda non fu mai la classica protettrice del focolaio domestico come avrebbe tanto voluto la madre Rachele. Lei amava le feste senza orari, il gioco d’azzardo (per il quale poteva perdere somme spaventose grazie ai continui rifornimenti del segretario del padre), il lusso sfarzoso, l’adrenalina, dividendosi senza sosta fra la bella casa ai Parioli, la villa del Castiglione a Capri e il Circolo del golf dell’Acquasanta alle porte di Roma: “Da bambina – confesserà molto avanti negli anni – ho disperatamente sognato di essere un uomo: un archeologo o un esploratore. Non mi sentivo tagliata per essere un’impeccabile padrona di casa, una madre modello, una nuora da manuale, insomma una perfetta donna qualunque”.
Quando nel 1933 Hitler salì al potere, le reazioni della coppia furono opposte: Edda esclamò “È qualcosa di straordinario”, mentre Galeazzo commentò “Mio Dio, è una catastrofe”. Da quell’episodio emersero chiaramente le inconfutabili differenze di temperamento e di ideologie: lei, movimentista e ammiratrice della forza brutale tedesca, lui, cultore della Francia e ostile all’idealismo germanico e al Führer (che lo chiamava “un ninnolo da salotto”), con un fondo paradossale di buon senso del tutto estraneo alla moglie.
I nazisti e il loro capo apprezzavano Edda proprio per la sua aggressiva sincerità e il granitico fervore ideologico, qualità che le garantirono un ruolo di rilievo nei rapporti diplomatici dell’Italia fascista e, molto probabilmente, la salvezza al momento della resa dei conti. “Dopo il 1934 ebbi numerose occasioni di incontrare Hitler […] e mi colpirono sempre l’estrema cortesia che mi dimostrava, le attenzioni quasi affettuose, e anche la sua pazienza”.
Accanita interventista, esultò allo scoppio della guerra, e non perse tempo a prendervi parte come crocerossina volontaria pur senza averne il brevetto: “Edda premeva su Galeazzo perché si rompessero gli indugi a favore dell’entrata in guerra dell’Italia. Si era già nel maggio del ’40 quando lei, estremamente innervosita e irritata, raggiunse il marito nell’ufficio di palazzo Chigi, col fermo proposito di affrontarlo a viso aperto e di sostenere l’urgenza di interrompere la lunga e sterile quaresima della non belligeran-za. Lei andava per protestare e per dirgli quanto si vergognava di vedere che l’Italia non si era ancora schierata al fianco dell’alleato tedesco. […] La stampa estera continuava a presentare Edda come un personaggio di primo piano. Nel maggio del ’40, un giornale egiziano, «Al Wafd al-Misri», scriveva che Mussolini si consigliava soltanto con la figlia. Il «Time» le fece l’onore d’una copertina, e un’altra rivista egiziana, «Ima-ges», arrivava a definirla «la donna più pericolosa d’Eu-ropa, la donna che guidava suo padre col pugno di ferro». C’era chi scriveva che lei col suo fascino aveva «soggiogato» perfino Hitler. Edda commentava che, a leggere quei giornali, le sembrava di essere contemporaneamente l’imperatrice della Cina Tsu-hsi, Caterina II di Russia, Caterina de Medici, la regina Vittoria, Mata Hari e, perché no?, anche Fouché e Richelieu. Ma aggiungeva che in verità aveva un solo grande rammarico: quello di non essere nata uomo”
Entrò così nel Corpo assistenziale presieduto dalla principessa Maria Josè, con la quale i rapporti furono sempre tesi ai limiti dell’odio. Imbarcata sulla nave ospedale Po nelle acque albanesi, nel marzo del 1941 si trovò a vivere il dramma del naufragio nella baia di Valona: rimase in acqua per cinque ore ma riuscì a scampare miracolosamente alla morte. Negli anni successivi continuò il volontariato in Russia, in Ucraina e poi in Sicilia, da dove, in seguito allo sbarco alleato e il dolore per una Palermo rasa al suolo dai bombardamenti, scrisse al padre una lettera di straordinaria durezza e franchezza, nella quale denunciava le condizioni miserabili delle popolazioni locali e, al tempo stesso, i segni ormai evidenti della disgregazione dell’apparato militare italiano.
La guerra segnò l’inizio del tragico destino della loro famiglia. Ciano, inizialmente fautore dell’accordo di “non belligeranza” con la Germania e promotore dell’invasione dell’Albania, perse gradualmente consensi e potere per la sua dubbia condotta e i noti rapporti segreti con il Re, fino alla destituzione arrivata nel 1943. Il 25 luglio dello stesso anno, al Gran Consiglio del Fascismo, votò per la caduta del suocero con cui i rapporti erano già incrinati da tempo, firmando la propria condanna a morte. Dopo l’8 settembre, fidandosi della sua antica amicizia con i nazisti, è Edda a commettere l’errore fatale di consigliare il suo “Gallo” a rifugiarsi presso l’ambasciata tedesca di Roma. Da lì infatti saranno portati non già in Spagna, come avevano sperato, bensì in Germania, dove fu subito chiara la sorte che aspettava l’ex ministro degli Esteri. Edda venne ricevuta da vari gerarchi (“si rivolgevano solo a me, come se mio marito non esistesse”) e da Hitler stessa che le parlò commosso assicurandole la vittoria del Reich, sentendosi replicare con disarmante franchezza: “No, la guerra è perduta! Il fascismo e il nazismo sono putrefatti! Forse siamo ancora in tempo a fare la pace almeno con uno dei nostri nemici. Con la Russia, per esempio.” Le sue parole resero chiaro che non ci sarebbe stata salvezza. Galeazzo venne riportato in Italia, processato e fucilato a Verona l’11 gennaio 1944. La sua “Deda” ingaggiò una battaglia disperata per salvarlo. Tentò fino all’ultimo di far leva sul cuore paterno che l’aveva sempre aiutata e assecondata, ma fu tutto vano. In un ultimo drammatico colloquio lei stessa confessò poi di aver rinnegato il genitore con queste precise parole: “Ti odio, ti disprezzo, non sei più mio padre”.
Edda riuscì a fuggire in Svizzera con i figli, ma dopo un anno trascorso fra depressione e dipendenze, nell’estate del ‘45 fu espulsa dalle autorità elvetiche e riaccompagnata alla frontiera. Non si fece neanche un giorno di carcere. Le autorità italiane si limitarono a condannarla a due miseri anni di confino alle Eolie, nonostante la pesantissima accusa di “aver provocato l’ingresso in guerra dell’Italia, vincendo le resistenze del padre ed avvalendosi del forte ascendente che esercitava su di lui”. Tuttavia il soggiorno si rivelerà tutt’altro che noioso per la vedova Ciano, poiché anche in un contesto e in un momento del genere (erano trascorsi appena sette mesi dall’uccisione del padre e ventitré da quella del marito), non impiegò molto tempo a farsi consolare da un maschione locale “alto, forte, col volto saraceno di certi siciliani arabi”. Ovviamente non stiamo parlando di un anonimo marinaio! Nel giro di pochi giorni dal suo arrivo a Lipari, Edda era infatti già perdutamente innamotata fra le braccia di Leonida Buongiorno, ufficiale di guerra nel Primo Battaglione Alpini «Ceva» e partigiano nella Resistenza in Francia. Buongiorno non era solo il capo del Pci eoliano rinato dopo la fine della dittatura, ma anche l’esponente di una famiglia antifascista entrata nella storia. Suo padre, Edoardo, musicista, era il socialista in contatto con le organizzazioni clandestine che avevano fornito le carte navali e preparato la sera del 27 luglio 1929 la fuga dei fratelli Rosselli da Lipari a Tunisi e poi a Parigi, finita con il loro assassinio.
Questa tanto paradossale quanto infuocata relazione resa pubblica molti anni più da Marcello Sorgi, ex direttore della Stampa (raccontata nel libro “Edda Ciano e il comunista” e di cui esiste anche una versione cinematografica del 2011 con Stefania Rocca e Alessandro Preziosi), era fatta di letture omeriche, insaziabili incontri segreti e costellata di continue lettere romantiche in francese e in inglese. Lei lo chiamava “Baiardo”, o “Lecret”, dal nome del generale che combatté per la liberazione di Cuba nel 1898, gli scriveva cose come: “la tempesta dei vostri telegrammi è deliziosa”. Lui le dichiarava: “voi per me potreste essere la donna ideale”. L’idillio durò poco. Dopo appena nove mesi, Edda aveva già finito di scontare la sua “condanna” grazie all’inspiegabile amnistia del ministro della Giustizia Palmiro Togliatti. Nonostante il sentimento vero per quell’uomo così diverso da lei, decise di tornare subito a Roma dai figli portandosi dietro un prezioso ricordo, il suo ritratto nudo eseguito a matita da Leonida.
Cominciarono mesi malinconici, fatti di nostalgia e gelosia. «Spero che voi siate infelice e soffriate a causa di Ellenica», scrive appena arrivata a Roma, tra un resoconto delle prime difficoltà da affrontare e del rischio di dover nuovamente lasciare l’Italia. E ancora: «Mio carissimo e unico comunista, vi amo assai. Adoro le vostre effusioni in inglese». E in un’altra lettera del 31 agosto ‘46: «Sono rammollita dal caldo. Sogno ad occhi aperti la calma delle notti di Lipari, dell’acqua blu, delle incantevoli sciocchezze che una voce a volte dolce e profonda mi sussurrava nell’orecchio». “Ellenica” tornò a trovarlo ancora due volte prima di quel definitivo addio sulla banchina del piroscafo a Palermo. Scoprì che lui aveva trovato una fidanzata meno “scandalosa” e in preda alla rabbia si tagliò i capelli a zero inviandogli le foto. L’ultima lettera di Edda per smentire il suo chiacchierato fidanzamento con il conte Pietro Capuano, il gioielliere caprese noto come Chanteclair, non ebbe risposta. Passeranno dieci anni prima di un ultimo nostalgico incontro sull’isola siciliana in cui si ritroveranno sessantenni nel 1971, davanti a una parete su cui lui aveva fatto incidere i versi omerici con le parole di Circe, in ricordo delle spensierate letture clandestine di un tempo: «Tu da solo col tuo cuore consigliati: io ti dirò le due rotte».
A prima vista sembra incredibile che, a meno di un anno dalla fine del conflitto, dalla tragica morte del padre e del marito, ma soprattutto dal crollo definitivo del fascismo e delle certezze che avevano sorretto la sua vita, Edda potesse legarsi sentimentalmente proprio a colui che rappresentava il nemico per eccellenza. Eppure, osservando con attenzione la sua biografia, non appare poi così sorprendente: la sua esistenza fu costantemente segnata da paradossi, capricci, egoismi e da una tensione continua tra ribellione e devozione, culminata nell’amore smisurato per un padre ingombrante come Benito Mussolini. Egli stesso confessava di non essere mai riuscito a domare quella figlia indocile e contraddittoria come era stato lui stesso (celebre la sua storia d’amore con l’ebrea Margherita Sarfatti).
In un’intervista rilasciata negli ultimi anni, un’Edda ormai anziana ma ancora lucida rievocava episodi inediti della storia italiana e pronunciava parole che ben si adattano tanto alla sua parabola personale quanto al destino del fascismo. Commentando l’esposizione del cadavere del Duce a piazzale Loreto, sottolineò come l’efferata violenza e l’odio del popolo altro non fossero che il rovescio di un amore immenso trasformato in furore. “Si odia ciò che si è molto amato”, dichiarò, riferendosi al corpo del padre martoriato, ma lasciando emergere, forse senza rendersene conto, un’affermazione che calzava perfettamente anche alla sua stessa vita.
La vita di Edda Ciano Mussolini è stata infatti il riflesso drammatico della storia del fascismo stesso: l’ascesa rapida e scintillante, l’ebbrezza del potere, la convinzione di essere intoccabile, seguite dal crollo rovinoso, dalla perdita e dall’abbandono. Un tragedia greca che trovò nel contrappasso la sua condanna più amara: finire vittima di quelle stesse dittature che aveva sostenuto con passione.
Morì a Roma nel 1995, a 85 anni, stroncata da una grave infezione renale per cui era ricoverata da tempo. Fu poi sepolta a Livorno, nel Cimitero della Purificazione, accanto al marito. Solo in punto di morte dichiarò di aver perdonato il padre, mentre sulla madre rispose tombale: “Lei ha difeso il suo uomo, io ho difeso il mio.”